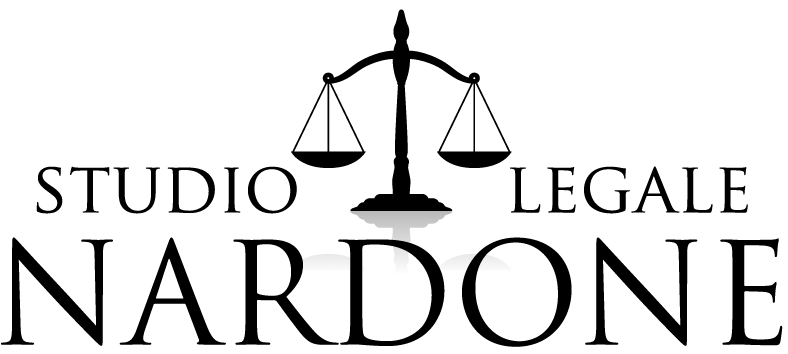Pubblicato il: 30/10/2025
Si tratta di un tema particolarmente rilevante per professionisti e titolari di partita IVA che esercitano l’attività all’interno della propria abitazione, o in ambienti a essa collegati.
Ai sensi dell’art. 52 del T.U. IVA e dell’art. 33 delle disp. accert. imp. redditi, gli organi di polizia tributaria possono accedere, senza particolari formalità, in qualsiasi locale in cui venga esercitata un’attività commerciale, industriale o professionale, al fine di eseguire controlli e verifiche fiscali.
Tuttavia, quando l’immobile oggetto di verifica è anche destinato ad abitazione privata, la disciplina cambia in modo sostanziale.
In tali ipotesi, infatti, l’accesso non può avvenire senza una specifica autorizzazione del Procuratore della Repubblica competente per territorio. La misura è volta a garantire il bilanciamento tra le esigenze di accertamento e la tutela del domicilio, costituzionalmente protetto dall’art. 14 Cost..
La categoria dei locali ad uso promiscuo è stata definita con precisione sia dalla Guardia di Finanza sia dalla Corte di Cassazione, la quale ha più volte chiarito che rientrano in questa fattispecie gli spazi nei quali si svolgono contemporaneamente la vita familiare e l’attività professionale.
È sufficiente, per integrare la promiscuità d’uso, che esista una comunicazione interna o un collegamento materiale tra le due aree, tale da consentire il trasferimento di documenti, registri o beni aziendali nella parte abitativa.
In tal senso, si richiamano le pronunce della Cassazione n. 6232/2015 e n. 37911/2022, che ribadiscono la necessità dell’autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria per l’accesso a immobili con tale duplice destinazione.
Diversa è la disciplina nei casi in cui i locali siano destinati esclusivamente a uso abitativo.
In tali circostanze, l’accesso può essere disposto solo in presenza di gravi indizi di violazioni tributarie e sempre previa autorizzazione del Procuratore della Repubblica. L’intervento ispettivo deve, inoltre, essere finalizzato ad attività precise, come la ricerca di libri contabili, scritture, denaro contante o altri elementi probatori utili a dimostrare l’evasione o l’elusione fiscale. Sul punto, Cassazione n. 7723/2018 ha confermato che l’autorizzazione giudiziaria costituisce un presidio essenziale di legittimità, volto a evitare accessi arbitrari nei domicili privati del contribuente.
Un ulteriore profilo di interesse riguarda gli immobili che, pur non avendo natura abitativa, sono utilizzati con modalità promiscue per scopi aziendali e personali. In tali situazioni, il provvedimento autorizzativo del magistrato mantiene funzione di garanzia, ma non richiede la presenza di indizi specifici di violazione, trattandosi di ordinaria attività ispettiva.
È il caso, ad esempio, di uno stabilimento industriale con annessi locali utilizzati dal titolare o da dipendenti a fini abitativi: l’autorizzazione è necessaria solo se l’accesso deve estendersi ai vani strettamente privati.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 1698/2022, ha chiarito che non si può parlare di uso promiscuo qualora gli ambienti aziendali e quelli domestici siano separati e collegati solo esternamente. In tali circostanze, per entrare nella parte privata, la Guardia di Finanza deve comunque munirsi di autorizzazione del Procuratore della Repubblica.
Ad ogni modo, quando l’Agenzia delle Entrate o la Guardia di Finanza avviano una verifica fiscale, l’attività di controllo segue un percorso ben preciso, articolato in più fasi.
La prima è quella dell’accesso, ossia l’ingresso degli ispettori nei locali dove si svolge l’attività. Da questo momento ha inizio la vera e propria verifica tributaria, che prosegue con controlli, acquisizione di documenti e colloqui con il contribuente o con i suoi rappresentanti. Ogni giornata di lavoro viene registrata attraverso specifici verbali, che descrivono nel dettaglio le operazioni compiute e le risultanze emerse.
Al termine delle operazioni, i verificatori redigono il processo verbale di contestazione (PVC), un atto formale che sintetizza gli esiti della verifica e individua le eventuali irregolarità fiscali riscontrate, suddivise per imposta e per periodo d’imposta. Nel verbale vengono indicati anche i soggetti presenti, le dichiarazioni rese, le circostanze di luogo e di tempo, e tutti gli elementi utili a documentare l’attività svolta. Il processo verbale di contestazione deve essere letto e consegnato in copia al contribuente, che può decidere se firmarlo oppure rifiutare la sottoscrizione. È importante sapere che qualsiasi dichiarazione firmata durante la verifica può essere utilizzata a suo sfavore in sede di accertamento o contenzioso.
La questione è stata, inoltre, oggetto di una recente ordinanza della Corte di Cassazione (25049 dell’11 settembre 2025). La vicenda riguardava il ricorso di un medico, sottoposto a un pesante accertamento fiscale basato su documenti acquisiti durante un accesso della Guardia di Finanza anche nella sua abitazione. Il professionista aveva contestato la legittimità dell’ispezione, sostenendo che mancassero i “gravi indizi” di violazioni fiscali richiesti dalla legge per autorizzare un intervento così invasivo. La Cassazione gli ha dato ragione, sancendo che l’Amministrazione finanziaria deve dimostrare la piena regolarità dell’autorizzazione rilasciata dal Pubblico Ministero.
Il punto centrale della decisione riguarda la c.d. motivazione per relationem: quando il magistrato autorizza l’accesso basandosi sui rilievi della Guardia di Finanza, la richiesta di quest’ultima diventa parte integrante della motivazione. Pertanto, se il contribuente ne contesta la validità, il Fisco ha l’obbligo di produrre in giudizio non solo il decreto di autorizzazione, ma anche la richiesta originaria della Finanza. In mancanza di quest’ultima, l’autorizzazione è considerata nulla e, di conseguenza, anche tutti gli atti impositivi fondati su di essa perdono efficacia.
Vai alla Fonte