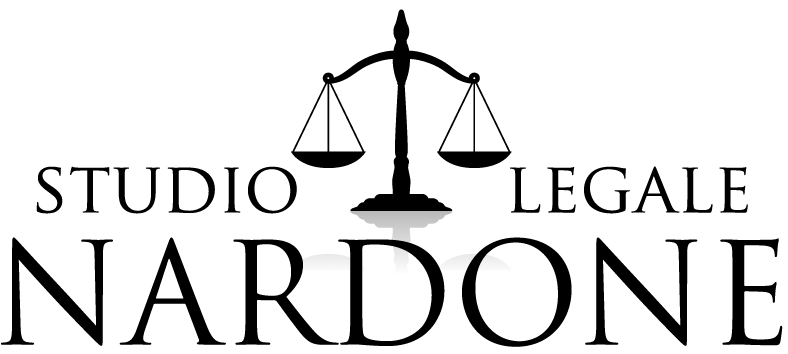Pubblicato il: 22/10/2025
Ma procediamo con ordine.
Nella fattispecie oggetto di causa, il proprietario di due appartamenti, colpiti da infiltrazioni di acqua piovana, conveniva in giudizio alcuni condomini del medesimo stabile, chiedendone la condanna all'esecuzione dei lavori necessari all’eliminazione delle cause delle lamentate infiltrazioni, dovute alla cattiva manutenzione del manto di copertura del fabbricato, dei cornicioni, dei canali di gronda e dei pluviali.
Parte attrice domandava, in subordine, il risarcimento dei danni per equivalente, nonché – e veniamo al punto che qui specificamente interessa – la condanna dei convenuti al pagamento di un "equo indennizzo" per il ridotto godimento delle due unità immobiliari.
In primo grado il Tribunale condannava i convenuti all'esecuzione delle opere indicate nella relazione del C.T.U., rigettando però la domanda di equo indennizzo.
La Corte d'Appello, invece, accoglieva il gravame proposto dall’attore, condannando i condomini responsabili anche al pagamento di una somma a tale titolo, somma determinata equitativamente in base ai canoni di locazione degli immobili ad uso residenziale e stagionale, applicati nell'ambito del territorio in cui si trovavano i beni oggetto di causa.
Avverso la decisione di secondo grado i condomini convenuti proponevano ricorso per Cassazione, articolato in quattro motivi:
- con il primo motivo di ricorso, si deduceva la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 115, 163 n. 4), 167 e 702 bis c.p.c., per avere la Corte d'Appello accolto la domanda di "equo indennizzo per il ridotto godimento dei due appartamenti" in totale assenza di specifiche allegazioni a sostegno della relativa pretesa;
- con il secondo motivo, veniva dedotta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2043 e 2056 c.c., in relazione agli artt. 1223, 1226 e 2697 c.c., per avere la Corte d'Appello erroneamente ritenuto sussistere un danno in re ipsa;
- con il terzo motivo, i ricorrenti lamentavano la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 191 e ss. c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., per avere la Corte territoriale posto a fondamento della condanna risultanze di fatto derivanti da C.T.U. ammessa in assenza dei presupposti di legge, in quanto meramente esplorativa;
- infine, con il quarto motivo di ricorso si sosteneva la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2043 c.c., 115 e 116 c.p.c., errores in procedendo e travisamento della prova, stante l'assenza di condotta dolosa o colposa imputabile ai ricorrenti.
Ebbene, la Suprema Corte ha considerato meritevole di accoglimento il primo dei motivi di ricorso, ritenendo assorbiti i restanti.
Esaminiamo i passaggi della decisione della Corte.
In primo luogo, i giudici di legittimità rammentano il proprio consolidato e risalente orientamento, secondo cui il proprietario ha pieno diritto di usare e godere della cosa propria secondo la naturale destinazione della stessa, per cui qualsiasi intervento di un terzo che sia diretto a limitare detto uso o godimento costituisce turbativa del diritto di proprietà sul bene e legittima, dunque, il proprietario a chiedere non solo la tutela in forma specifica, mediante cessazione di tale turbativa e ripristino della situazione antecedente al verificarsi dell'illecito, ma anche il risarcimento dei danni; arrivando spesso alla conclusione che il danno, in tale ipotesi, è in re ipsa, in quanto automatica conseguenza della limitazione del godimento e della diminuzione temporanea del valore della proprietà, senza neppure che vi sia necessità di una specifica attività probatoria, salva concreta determinazione del danno stesso in sede di liquidazione, cui eventualmente procedere anche in via equitativa.
Sul punto la pronuncia in esame richiama altresì talune sentenze delle Sezioni Unite (n. 33645 e n. 33659 del 2022) che, riguardo al tema specifico del risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, hanno precisato come il proprietario sia tenuto ad allegare la concreta possibilità di godimento andata perduta e lo specifico pregiudizio subito.
Di tali elementi, in caso di puntuale contestazione da parte del convenuto, il danneggiato è chiamato a fornire la prova, anche mediante presunzioni o richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza.
In ogni caso, se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, eventualmente tramite il parametro del canone locativo di mercato (si veda anche Cass. n. 30791 del 2024).
Quindi, è preciso onere dell'attore allegare – entro le previste scadenze processuali che cristallizzano il thema decidendum – il fatto produttivo del danno al bene di sua proprietà.
In particolare, l’allegazione del danno alla proprietà postula che l'attore indichi nella domanda, o comunque entro il termine per precisare la stessa, quegli elementi di fatto noti che consentano di risalire, in via di presunzione, al fatto ignoto, e cioè alla conseguenza lesiva.
L'allegazione che deve, pertanto, accompagnare la proposizione di una domanda risarcitoria non può essere limitata – chiarisce la S.C. – alla prospettazione della condotta, asseritamente colpevole, della controparte, produttiva di danni nella sfera giuridica di chi agisce in giudizio.
L'esposizione deve, viceversa, estendersi alle lesioni prodotte da tale condotta, poiché l'attore deve mettere il convenuto in condizione di conoscere quali pregiudizi vengono imputati al suo comportamento.
Tale allegazione esigibile dall'attore deve, ribadisce la Cassazione, concernere fatti precisi e specifici del caso concreto, essere cioè circostanziata, non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere del tutto generico e astratto, eventuale ed ipotetico (Cass. n. 10527 del 2011; n. 21060 del 2016; n. 7604 del 2025).
Proprio questo era, invece, avvenuto – ad avviso degli Ermellini – nel caso di cui ci stiamo occupando.
In altre parole, la domanda di condanna dei convenuti "ad equo indennizzo per il ridotto godimento dei n. 2 appartamenti" non poteva ritenersi comprensiva del danno subito per lo svolgimento – negli immobili stessi – dell'attività di affittacamere, trattandosi di elemento di fatto che non era stato espressamente allegato nell'atto introduttivo o, comunque, entro il termine per la maturazione delle preclusioni processuali assertive.
La mancata, tempestiva allegazione non poteva neppure essere “sanata” per mezzo delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, dal momento che le indagini peritali devono comunque vertere su elementi già allegati dalla parte.
In sostanza, nella fattispecie de qua parte attrice avrebbe avuto lo specifico onere di indicare, tra i fatti posti a fondamento della domanda, la effettiva destinazione economica del bene e la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento (locazione a terzi), che si assumeva perduta in conseguenza delle infiltrazioni presenti nell'immobile.
La Suprema Corte ha, perciò, annullato con rinvio la sentenza impugnata.
Vai alla Fonte