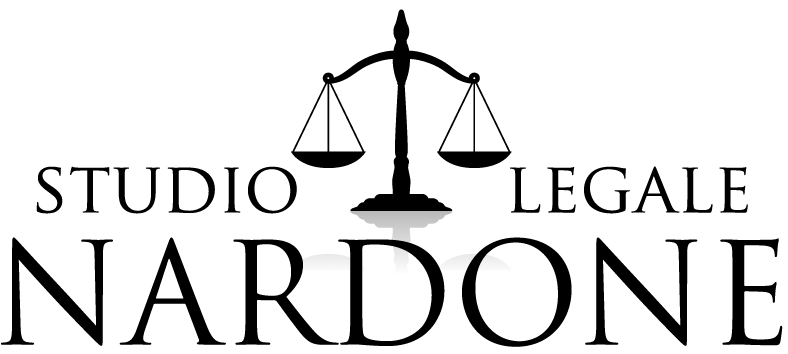Pubblicato il: 17/10/2025
Una sentenza destinata a far tremare le gambe di migliaia di ciclisti e motociclisti italiani è stata depositata il 17 settembre scorso. Con la decisione numero 7353/2025, il Consiglio di Stato ha dato ragione ai Comuni che vogliono multare pesantemente chiunque leghi la propria bicicletta o moto a pali, cancellate o altre strutture pubbliche non specificamente destinate al parcheggio. La motivazione ufficiale? La tutela del decoro urbano. Il risultato pratico? Sanzioni che possono arrivare fino a 800 euro per chi osa incatenare il proprio mezzo a un sostegno "non autorizzato".
La questione nasce da un ricorso presentato dalla Fiab di Cagliari contro l'articolo 19 del Regolamento di polizia e sicurezza urbana del capoluogo sardo, che vieta espressamente di legare velocipedi e motocicli a infrastrutture pubbliche inadatte. Il sistema sanzionatorio previsto dal Comune è particolarmente severo: si parte da una multa base compresa tra 75 e 500 euro ma, se l'infrazione viene commessa in zone di particolare pregio storico o artistico, scatta una sanzione aggiuntiva tra 100 e 300 euro. Facendo due calcoli, nel caso peggiore un cittadino può trovarsi a pagare 800 euro per una bici incatenata al posto sbagliato. Una cifra che, spesso, supera il valore stesso del mezzo e che appare del tutto sproporzionata rispetto alla natura dell'infrazione.
La Federazione italiana ambiente e bicicletta aveva sollevato tre obiezioni fondamentali contro questo regolamento. Primo: il Comune avrebbe introdotto una nuova tipologia di divieto di sosta, non contemplata dal Codice della Strada, esercitando così un potere che non gli compete.
Secondo: esisterebbe una violazione del principio di uguaglianza, dato che il divieto colpisce solo bici e moto ma non monopattini elettrici e segway.
Terzo: le sanzioni previste sarebbero manifestamente sproporzionate rispetto alla gravità del fatto. Il Consiglio di Stato, confermando quanto già stabilito dal Tar in primo grado, ha respinto tutte queste argomentazioni, chiarendo che la norma non regola la sosta dei veicoli, ma mira esclusivamente a preservare il decoro degli spazi pubblici, e che non c'è discriminazione perché le situazioni prese in esame non sono comparabili tra loro.
Secondo: esisterebbe una violazione del principio di uguaglianza, dato che il divieto colpisce solo bici e moto ma non monopattini elettrici e segway.
Terzo: le sanzioni previste sarebbero manifestamente sproporzionate rispetto alla gravità del fatto. Il Consiglio di Stato, confermando quanto già stabilito dal Tar in primo grado, ha respinto tutte queste argomentazioni, chiarendo che la norma non regola la sosta dei veicoli, ma mira esclusivamente a preservare il decoro degli spazi pubblici, e che non c'è discriminazione perché le situazioni prese in esame non sono comparabili tra loro.
Il paradosso della mobilità sostenibile: ti incentivano a pedalare, poi ti multano
Dietro l'apparente nobiltà del concetto di decoro urbano si nasconde un paradosso, che colpisce la credibilità delle politiche di mobilità sostenibile. Le amministrazioni comunali, da un lato, promuovono a gran voce l'uso della bicicletta come soluzione virtuosa per ridurre traffico e inquinamento; dall'altro, creano le condizioni per punire severamente chi questa scelta la compie davvero. Il problema di fondo, sistematicamente ignorato, è la cronica mancanza di rastrelliere e spazi sicuri dove parcheggiare i mezzi a due ruote.
Chi usa quotidianamente la bicicletta in città sa perfettamente che le poche rastrelliere disponibili sono spesso insufficienti, mal posizionate o in condizioni pietose. Di fronte all'alternativa tra lasciare il proprio mezzo debolmente assicurato a una rastrelliera fatiscente – con il rischio quasi certo di ritrovarlo smontato o sparito – e legarlo saldamente a un palo robusto, la scelta è obbligata. Il furto di biciclette è una piaga dilagante nelle città italiane, con migliaia di denunce ogni anno e tassi di recupero vicini allo zero. Il ciclista che incatena la sua bici a un sostegno solido non lo fa per spregio delle regole o per deturpare il paesaggio urbano, ma per legittima difesa del proprio patrimonio.
La sentenza del Consiglio di Stato, pur formalmente ineccepibile sul piano giuridico, legittima un approccio che punisce il sintomo invece di curare la malattia. Invece di investire risorse nella creazione di infrastrutture adeguate, si sceglie la strada più semplice della repressione. Il decoro urbano diventa così uno slogan vuoto, un comodo paravento dietro cui nascondere l'incapacità o la mancanza di volontà politica di affrontare seriamente il problema. Si crea un sistema perverso in cui il cittadino viene sollecitato ad adottare comportamenti virtuosi e, poi, viene penalizzato per le inevitabili conseguenze pratiche di quella scelta, trovandosi tra l'incudine del furto e il martello della multa.
800 euro per una bici al palo: sanzione o rapina legalizzata?
La questione della proporzionalità delle sanzioni merita un'attenzione particolare, perché tocca un principio fondamentale del diritto: la sanzione deve essere commisurata alla gravità dell'illecito. Nel caso specifico di Cagliari, parliamo di multe che possono raggiungere gli 800 euro complessivi, una cifra che lascia sgomenti se confrontata con altre infrazioni, ben più gravi, previste dal Codice della Strada.
Per fare un esempio concreto, chi guida senza cintura di sicurezza rischia una sanzione molto inferiore, eppure si tratta di un comportamento che mette a rischio la vita. Una bicicletta legata a un palo rappresenta, forse, un pericolo analogo? Evidentemente no.
Per fare un esempio concreto, chi guida senza cintura di sicurezza rischia una sanzione molto inferiore, eppure si tratta di un comportamento che mette a rischio la vita. Una bicicletta legata a un palo rappresenta, forse, un pericolo analogo? Evidentemente no.
Il Consiglio di Stato ha sostanzialmente eluso la questione della proporzionalità, affermando che soltanto l'applicazione concreta della sanzione, valutata caso per caso, potrà eventualmente essere contestata con un ricorso specifico. Questa posizione, però, finisce per legittimare l'esistenza stessa di una sanzione massima abnorme. Si apre così la porta a un sospetto inquietante: che dietro questi rigidi regolamenti non si nasconda tanto la volontà di educare i cittadini al rispetto degli spazi pubblici, quanto piuttosto una logica di cassa.
Per le amministrazioni comunali, cronicamente a corto di fondi, le multe rappresentano una fonte di entrata sempre più rilevante nei bilanci. Sanzioni così elevate possono trasformarsi in un modo per fare cassa sulle spalle di chi sceglie mezzi di trasporto ecologici. Una sanzione, per essere davvero efficace, deve avere una funzione educativa e deterrente, ma deve anche essere percepita come equa dai cittadini. Una multa da diverse centinaia di euro per una bicicletta appoggiata al posto sbagliato non viene percepita come giusta, bensì come una vera e propria stangata, un'ingiustizia che rischia di produrre l'effetto opposto a quello desiderato: scoraggiare l'uso della bicicletta e alimentare la sfiducia verso le istituzioni.
Veicolo a tutti gli effetti, ma senza gli stessi diritti delle auto
C'è un aspetto tecnico fondamentale che la sentenza stessa richiama e che vale la pena approfondire: la bicicletta, secondo il Codice della Strada, è classificata come veicolo a tutti gli effetti. Questa equiparazione comporta che chi la utilizza deve rispettare le medesime regole generali sulla circolazione e sulla sosta previste per gli altri mezzi. In teoria, una bicicletta lasciata in sosta irregolare sul marciapiede o in un luogo vietato può essere sanzionata e persino sottoposta a rimozione forzata, esattamente come accadrebbe per un'automobile.
Il problema è che questa equiparazione funziona solo in una direzione. Al ciclista vengono imposti i doveri di un conducente di veicolo a motore, ma non gli vengono riconosciuti i medesimi diritti in termini di infrastrutture dedicate. Se ogni automobile può contare su una rete capillare di parcheggi, che siano a pagamento con strisce blu, gratuiti con strisce bianche o riservati con strisce gialle, lo stesso non si può dire per le biciclette. Gli spazi dedicati sono pochi, spesso mal distribuiti e insufficienti a soddisfare la domanda crescente.
L'utente della mobilità dolce si ritrova, così, in una condizione di estrema vulnerabilità: da una parte è esposto al rischio concreto e quotidiano del furto se non assicura adeguatamente il proprio mezzo a un sostegno robusto; dall'altra parte rischia sanzioni economicamente devastanti, se quel sostegno non è quello "autorizzato" dall'amministrazione. Questa sentenza, pur mettendo un punto su una controversia specifica, finisce per aggravare l'incertezza normativa e aumentare la pressione su milioni di cittadini che vorrebbero contribuire a costruire città più vivibili e sostenibili. Invece di trovare sostegno e facilitazioni, si scontrano con un sistema che sembra pensato per ostacolarli e, nei fatti, per punirli. Il rischio concreto è che il decoro urbano diventi un pretesto per una nuova forma di tassazione occulta ai danni di chi fa scelte ecologiche.
Vai alla Fonte