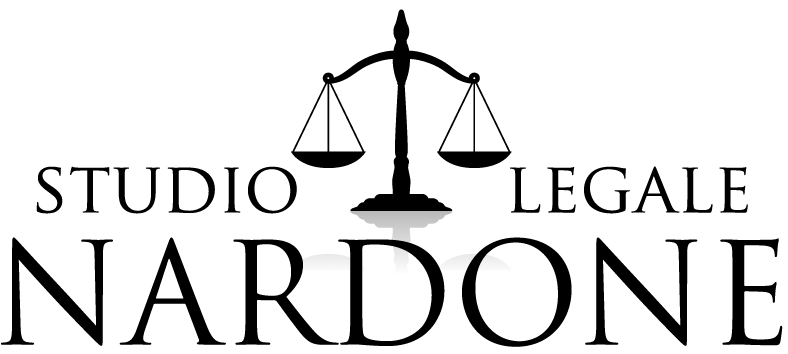Pubblicato il: 16/10/2025
In altre parole, quando le scritture contabili di un'impresa non sono credibili o presentano errori formali, non sarà più il Fisco a dover dimostrare in modo pieno e diretto l'esistenza di redditi occultati per pagare meno tasse, ma sarà il contribuente a dover provare la correttezza del proprio operato. Si tratta di una vera e propria inversione dell'onere della prova, che potrebbe cambiare le strategie difensive in molti contenziosi tributari.
Il caso pratico da cui trae origine l'ordinanza riguarda un'operazione di frode fiscale scoperta dalla Guardia di Finanza. In particolare, una società era stata accusata dalle Entrate di utilizzare fatture false emesse da imprese "cartiere", ossia entità fittizie prive di struttura, personale, mezzi e attività economica, create unicamente per generare costi fittizi e ridurre l'imponibile fiscale, agevolando così le frodi fiscali (come evasione e riciclaggio di denaro) a vantaggio di altre società.
Dopo la verifica, l'Agenzia delle Entrate aveva rettificato la base imponibile con il metodo di accertamento analitico-induttivo fondato su molteplici elementi gravi e concordanti: la falsità delle fatture, i rapporti commerciali inesistenti e le discordanze ai fini IVA. Tale accertamento è previsto dall'art. 39 del D.P.R. 600/1973 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) e comporta che, al fine di provare l'esistenza di componenti di reddito positivi non dichiarati, il Fisco può avvalersi di presunzioni semplici, a patto che queste posseggano i requisiti di gravità, precisione e concordanza di cui all'art. 2729 del c.c., acquisendo così valore probatorio.
Nonostante ciò, la Commissione tributaria regionale aveva annullato l'atto di accertamento, ritenendo carente il metodo di calcolo dei ricavi presunti e, comunque, non sufficiente a dimostrare le responsabilità della società.
La disputa proseguì in Cassazione, dove la decisione fu ribaltata: secondo i giudici di legittimità, prima di contestare il metodo di calcolo, i giudici di merito avrebbero dovuto riconoscere la palese inattendibilità della contabilità. Anzi, una volta accertata tale inattendibilità, l'Agenzia era pienamente legittimata a utilizzare le presunzioni per ricostruire il reddito effettivo.
In particolare, la Sezione Tributaria della Corte ha chiarito che, di fronte a contabilità incomplete, errate o mendaci, l'amministrazione finanziaria non è vincolata ai dati ufficiali dichiarati dall'impresa, ma può superare tali risultanze e procedere con il citato accertamento analitico-induttivo, il quale semplifica le attività di ricostruzione del reddito imponibile, consentendo al Fisco di valutare i dati contabili sulla base di elementi indiziari, purché questi siano gravi, precisi e concordanti, e – quindi – idonei a fondare una presunzione attendibile di maggiori ricavi o minori costi.
In breve, questo metodo consente di integrare o correggere le scritture contabili partendo da elementi certi e utilizzando presunzioni semplici – cioè deduzioni logiche tratte da fatti noti (ad esempio scostamenti evidenti tra entrate e uscite) – per risalire a fatti ignoti, come la presenza di redditi in nero.
Una volta che l'Agenzia delle Entrate ha costruito un impianto indiziario coerente, l'onere di provare il contrario si sposta sul contribuente: è quest'ultimo – spiega la Cassazione nell'ordinanza n. 27118 – che deve fornire documenti, spiegazioni e prove concrete per dimostrare che le conclusioni del Fisco non corrispondono al vero. Con questa decisione destinata a fare giurisprudenza, la Corte ridefinisce la regola processuale ordinaria prevista nell'art. 2697 del c.c., secondo cui chi vuol far valere un diritto (in questo caso il Fisco) deve dimostrarlo: in presenza di contabilità inattendibili, questa regola subisce una deroga sostanziale.
Perciò, se un'impresa utilizza fatture per operazioni inesistenti, si può ragionevolmente presumere che abbia generato ricavi non dichiarati per alimentare flussi finanziari occulti. E, quando tali presunzioni sono gravi, precise e concordanti, esse hanno lo stesso valore probatorio delle prove dirette come – ad esempio – le testimonianze.
Secondo la linea adottata dalla Corte, al contribuente non basta più criticare il metodo o il calcolo adottato dal Fisco: deve invece dimostrare, in modo puntuale e documentato, di non aver commesso alcuna irregolarità. In caso contrario, la ricostruzione presuntiva dell'Agenzia resta valida. Va da sé che sulle spalle del contribuente penda, così, l'arduo onere di provare un fatto negativo – ossia la non esistenza di redditi occulti – in un contesto in cui la contabilità è già considerata inattendibile.
Sul piano sistemico, l'ordinanza della Cassazione rafforza gli strumenti a disposizione del Fisco nella lotta alle frodi e alle evasioni fiscali. Tuttavia, il principio affermato dai giudici di piazza Cavour presenta un potenziale effetto collaterale: infatti, la sua applicazione estensiva potrebbe colpire anche imprese oneste, ma con contabilità imprecise o affette da errori formali, che – tuttavia – non sono segnale della volontà di ingannare le Entrate.
In questi casi, il rischio concreto è che l'accertamento induttivo costringa l'imprenditore a difendersi da presunzioni difficili da confutare, con l'effetto pratico della limitazione delle garanzie del contribuente, che si troverebbe a dover provare la propria innocenza partendo da una posizione processualmente di netto svantaggio. Ecco perché l'ordinanza n. 27118 della Cassazione suggerisce una maggiore attenzione nella tenuta e nella trasparenza delle scritture contabili, perché la minima incoerenza può diventare il punto di partenza per un accertamento basato su presunzioni.
Vai alla Fonte